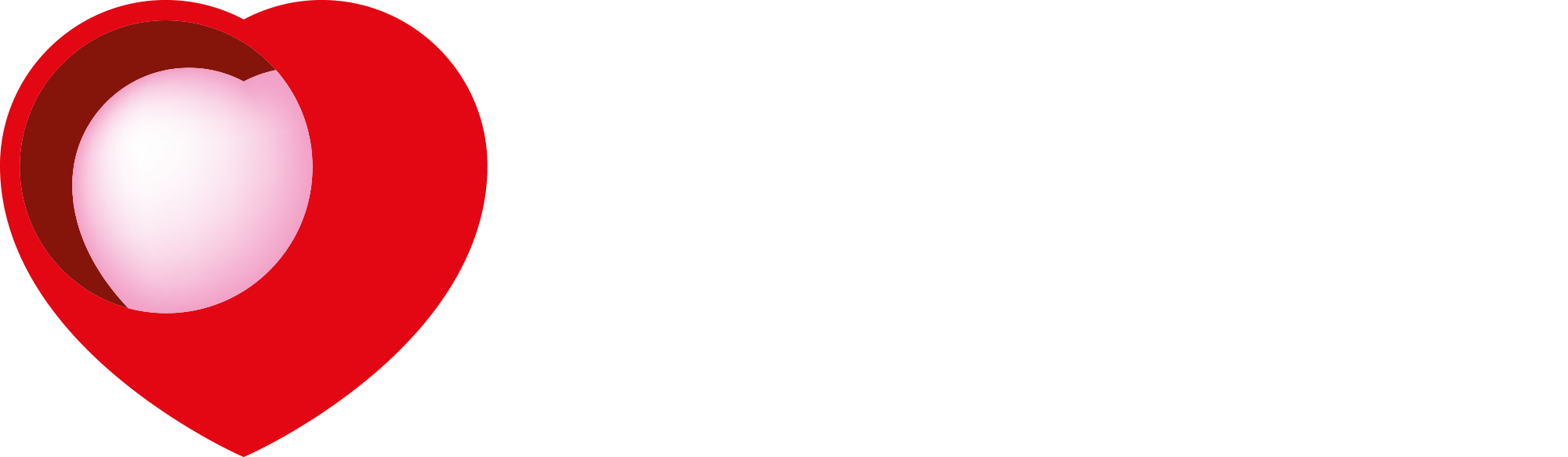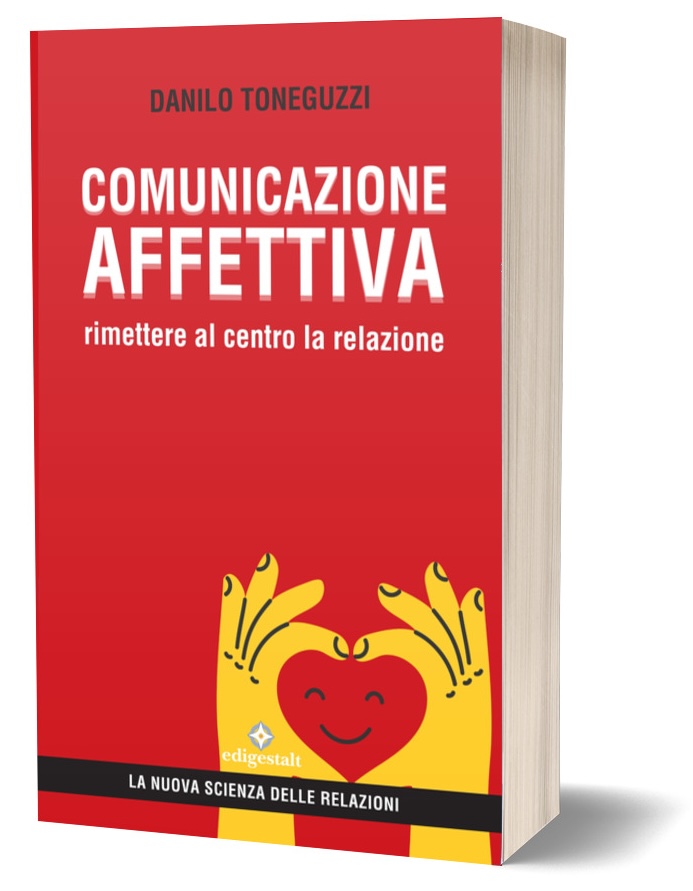Negli ultimi anni, la comprensione della comunicazione e delle relazioni umane ha subito un’importante evoluzione grazie all’apporto delle neuroscienze.
Tra i contributi più rilevanti in questo campo, spicca la Teoria Polivagale, elaborata dal neuroscienziato Stephen Porges, che offre un nuovo modello interpretativo per leggere i comportamenti sociali, le reazioni emotive e la qualità della connessione interpersonale.
Questa teoria ha trovato numerose applicazioni in ambito clinico, educativo e relazionale, e si rivela particolarmente utile per comprendere i presupposti neurofisiologici della Comunicazione Affettiva, ossia il modello di comunicazione interpersonale che si fonda sulla sicurezza emotiva, sull’empatia e sulla capacità di co-regolazione.
Il sistema nervoso autonomo e la regolazione relazionale
Tradizionalmente, il sistema nervoso autonomo (SNA) veniva suddiviso in due componenti principali:
- il sistema simpatico, responsabile dell’attivazione energetica e delle risposte di attacco o fuga;
- il sistema parasimpatico, associato a funzioni di riposo e recupero.
La Teoria Polivagale introduce un elemento innovativo: non esiste un solo sistema parasimpatico, ma due rami distinti del nervo vago, ciascuno con funzioni diverse e specifiche. Questi tre sistemi (simpatico, vago dorsale e vago ventrale) si attivano in modo gerarchico, sulla base della percezione — automatica e pre-razionale — di sicurezza, pericolo o minaccia:
- Sistema vagale ventrale È la più recente acquisizione evolutiva del sistema nervoso autonomo. È connesso alle aree del cervello deputate alla regolazione emotiva, all’empatia e alla connessione sociale. Quando è attivo questo sistema, il soggetto si sente calmo, al sicuro e in grado di stabilire relazioni positive, perché è strettamente collegato al Sistema di Coinvolgimento Sociale che, nei mammiferi, rappresenta la strategia di adattamento più funzionale. In questo stato, è possibile sentire la connessione con gli altri esseri e comunicare, così, in un paradigma di riconoscimento e collaborazione: la voce è calda, il volto è espressivo, lo sguardo è aperto.
- Sistema simpatico Si attiva in presenza di un “pericolo” percepito. Predispone il corpo a reagire attraverso la modalità difensiva basata sulla mobilizzazione dell’energia: l’attacco o la fuga. Il soggetto, quando il sistema simpatico prende il sopravvento, può apparire agitato, iperattivo o aggressivo. In questo stato, la comunicazione diventa reattiva, difensiva, e spesso conflittuale.
- Sistema vagale dorsale È il ramo più antico e si attiva quando la percezione è quella della “minaccia per la sopravvivenza”. Innesca una risposta di blocco, o “freezing”: chiusura, rallentamento o dissociazione. Il soggetto può manifestare apatia, ritiro emotivo o assenza di reazione. In questo stato, la comunicazione si interrompe: non si ha accesso né all’espressione né all’ascolto profondo.
La Teoria Polivagale e la comunicazione interpersonale
L’aspetto più rilevante della Teoria Polivagale, ai fini della comunicazione e delle relazioni umane, è che l’accesso al Sistema di Coinvolgimento Sociale è subordinato alla percezione di sicurezza. È un meccanismo neurobiologico istintivo: il Sistema Nervoso, attraverso le sue funzioni percettive che Porges definisce “neurocezione”, valuta i segnali che arrivano dall’esterno e risponde in base alla percezione di “sicurezza”, “pericolo” o “minaccia per la sopravvivenza”.
Questo significa che la qualità di una conversazione o di un’interazione non dipende soltanto dal contenuto verbale, ma soprattutto dallo stato neurofisiologico dei soggetti coinvolti. Quando il sistema vagale ventrale è attivo, il cervello è in grado di regolare le emozioni, di riconoscere le intenzioni dell’altro, di mantenere la calma e di utilizzare un linguaggio affettivo. Al contrario, in uno stato di attivazione simpatica o di chiusura dorsale, le risorse cognitive ed empatiche si riducono drasticamente.
La Comunicazione Affettiva come facilitatrice della sicurezza
Il modello della Comunicazione Affettiva, che si fonda sull’integrazione tra la teoria dell’attaccamento, l’intelligenza emotiva e i principi della neurobiologia interpesonale, riconosce pienamente la centralità della sicurezza emotiva.
Secondo questo approccio, per poter comunicare in modo autentico e trasformativo, è necessario che il Sistema Nervoso percepisca l’altro come non minaccioso, e il contesto relazionale come accogliente e prevedibile. Da qui ne deriva l’importanza, nel modello della Comunicazione Affettiva, del “paradigma relazionale” dal quale gli interlocutori si rivolgono l’un l’altro: la percezione e la considerazione dell’altro, cioè, condizionano inevitabilmente le intenzioni relazionali e il comportamento comunicativo (quello che diciamo e come lo diciamo) che determinano, di fatto, la qualità della comunicazione stessa. La percezione dell’interlocutore, quindi, è ciò che fa la differenza.
La Comunicazione Affettiva non si limita dunque all’adozione di tecniche o strategie comunicative, ma promuove una vera e propria esperienza relazionale di regolazione reciproca. Quando comunichiamo da un paradigma di riconoscimento reciproco, attraverso il tono della voce, il linguaggio del corpo, la qualità della presenza, è possibile influenzare positivamente lo stato neurofisiologico dell’altro e promuovere un dialogo fondato sulla fiducia e sulla comprensione.
La regolazione interpersonale come chiave delle relazioni sane
Un altro contributo fondamentale della Teoria Polivagale riguarda il concetto di co-regolazione: la capacità di due sistemi nervosi in relazione di influenzarsi reciprocamente in modo positivo.
In una relazione positiva e funzionale, fondata su un paradigma di riconoscimento reciproco, ciascun individuo diventa fonte di sicurezza per l’altro.
Questa sicurezza permette di affrontare i momenti di difficoltà senza ricorrere a modalità difensive, e di ripristinare rapidamente la connessione anche dopo un conflitto. Ad esempio, in ambito educativo, terapeutico, ma anche familiare, la qualità della comunicazione dipende in gran parte dalla capacità dell’adulto (genitore, insegnante, terapeuta) di offrire un campo relazionale regolato, che favorisca l’attivazione del sistema vagale ventrale del bambino o dell’interlocutore.
La Teoria Polivagale, quindi, rappresenta un’importante base scientifica per comprendere le dinamiche profonde della comunicazione umana.
Essa dimostra che la sicurezza è una condizione biologica essenziale per l’attivazione delle funzioni sociali superiori: empatia, ascolto, linguaggio affettivo, cooperazione. Il modello della Comunicazione Affettiva si inserisce pienamente in questa visione, offrendo strumenti relazionali e formativi che promuovono la sicurezza, la regolazione emotiva e la connessione autentica.
In un tempo in cui le relazioni sono spesso segnate da incomprensioni, reattività e distacco, tornare a comprendere la centralità del corpo, del sistema nervoso e dell’esperienza di sicurezza può rappresentare un punto di svolta tanto nella sfera privata quanto in quella professionale.
Danilo Toneguzzi
PS: Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo nei tuoi canali!